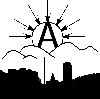Over 30 years of anarchist writing from Ireland listed under hundreds of topics
NO LOGO, di Naomi Klein
La pubblicazione di questo libro è stata perfettamente, anche se non volutamente, tempestiva. Non si erano ancora spenti gli spot mediatici sulle manifestazioni di Seattle del 30 novembre 1999, che usciva il libro a spiegare molte delle ragioni di quel movimento. Ed anche se la Klein ha chiarito che lei non è una portavoce ufficiale del movimento e che questo movimento non ha portavoce ufficiali, il libro ha dato molte risposte ad osservatori ed anche a manifestanti che si stavano chiedendo cosa stava accadendo.La Klein comincia evidenziando quanto siano mutate le strategie di mercato e di pubblicità negli ultimi 20 anni. Le compagnie hanno deciso che il problema essenziale non sta più nel vendere i propri prodotti, dal momento che questi sono generici, possono essere copiati e addirittura migliorati. Ma se si vende un'idea, un'esperienza, un gruppo di società, diventa molto più difficile la competizione. L'abbigliamento sportivo è un esempio significativo: si tratta di un mercato dove il prezzo e persino la qualità non hanno più importanza, dal momento che la gente sceglie tra la Nike e l'Adidas, non per le scarpe, ma per le loro campagne pubblicitarie.
Allo stesso tempo, mentre le compagnie si concentravano sui marchi anziché sui prodotti, iniziavano ad abbandonare il settore manifatturiero. Possedere una fabbrica viene ritenuto un grave vincolo, perchè comporta spese per il costo del lavoro, i capannoni e gli impianti. Certo il manifatturiero continua ad esistere, ma viene appaltato ad altri, così il problema della contrattazione aziendale diventa il problema di questi e la compagnia potrà concentrarsi sulla strategia del marchio.
Oggi un numero crescente di attività manifatturiere dell'abbigliamento, della componentistica per computer ed altre industrie sono state delocalizzate in paesi in via di sviluppo. Diversamente che in occidente, dove i salari sono decenti ed i lavoratori sono organizzati per ottenerli, nelle zone di libero scambio della Cina, Indonesia, Filippine, Messico e molti altri paesi, le aziende funzionano senza alcuna interferenza esterna. La descrizione delle condizioni di lavoro in questi paesi, dove si può arrivare a 100 ore settimanali di lavoro in condizioni spaventose, è la parte più interessante e più utile nel libro. I lavoratori ricevono un salario di sussistenza e sono spesso a lavoro obbligatorio straordinario non retribuito. La maggior parte della forza lavoro in queste aziende è costituita da giovani donne, emigrate da altre province, che vengono considerate facilmente dominabili ed incapaci di organizzarsi. E se le lavoratrici si sindacalizzano, scattano i licenziamenti; e se ci sono mobilitazioni su vasta scala, le aziende minacciano di spostarsi in un'altra zona. La solidarietà con questi lavoratori/trici e l'indignazione per le loro condizioni di vita sono state tra le forze propulsive per le manifestazioni di Seattle e Praga.
Dove il libro non convince è quando la Klein cerca di collegare i diversi temi suddetti. Ella cerca di sostenere che le compagnie devono spendere più risorse sul marchio, ed è per questa ragione che la produzione si sta spostando verso gli "sweatshops" (luoghi di lavoro a duro sfruttamento, ndt).Le compagnie non possono permettersi di avere la proprietà delle fabbriche e del marchio, così si sbarazzano delle prime. Ma non sono solo i grandi marchi ad essere fabbricati negli sweatshops. I prodotti della Nike possono essere fatti in Indonesia, ma lo sono anche quelli di marchio che troviamo nei supermercati. Lo stesso vale per le magliette Gap che troviamo nei grandi magazzini. Gli sweatshops non sono la conseguenza della politica del marchio, bensì sono il prodotto della volontà delle compagnie di tagliare i costi. Alcune compagnie potranno così abbassare i prezzi, mentre altre spenderanno di più in promozione, con la speranza di rifarsi con prezzi più alti.
Gli sweatshops non sono poi nulla di nuovo. Esistevano in occidente già un secolo fa insieme alle fabbriche infernali ed alle miniere insicure, e non certo perché i capitalisti di epoca vittoriana avessero scoperto la pubblicità e la promozione. Come non cogliere dei parallelismi tra le donne cinesi di oggi chiuse a chiave in fabbrica dai padroni del tessile con grave rischio di morte per gli incendi, e quello che successe agli inizi del XX° secolo a New York nel tristemente famoso incendio della fabbrica tessile Triangle Shirtwaist? (da cui poi l'8 marzo, ndt). I padroni cercano sempre di tagliare i costi, dato che salari decenti e luoghi di lavoro sicuri sono una perdita nei loro profitti. Ed i miglioramenti nelle condizioni di lavoro non sono venute dal buon cuore dei padroni, ma ogni aumento salariale, ogni riduzione di orario, ogni standard di sicurezza è costato dure lotte. Alle stesso conflitto assistiamo oggi, ed è una battaglia contro il capitalismo, non contro le etichette.
Quindi NO LOGO è in ultima analisi un libro deludente. E quando tenta di essere costruttivo e suggerisce azioni di lotta, punta troppo a sovvertire la pubblicità o a pitturare i cartelloni pubblicitari. La pubblicità può importunare o può essere divertente ma non modifica nulla in realtà. La Klein si dilunga in suggerire boicottaggi del consumo, anche quando ne ammette la debolezza intrinseca. Va detto che i boicottaggi possono essere efficaci quando hanno un singolo e chiaro obiettivo, come nel caso del boicottaggio della Shell in Nigeria (ricordate la lotta degli Ogoni?, ndt). Altrimenti producono una risposta delle compagnie fatta di scuse e di riverniciatura apparente, se non uno sfruttamento della situazione, come nel caso della Reebok che si pose quale alternativa etica alla Nike sotto accusa per i suoi sweatshops; va da sé che la Reebok adotta la stessa prassi di sfruttamento di cui è accusata la Nike.
Nel libro non c'è molto spazio all'esplorazione di modi per aiutare da qui, in occidente, i lavoratori sfruttati negli sweatshops, sia dal punto di vista sindacale che di solidarietà alle loro lotte, cosa che dovrebbe essere l'obiettivo di ogni boicottaggio. Tuttavia NO LOGO è un libro interessante e si pone come utile introduzione per coloro che vogliono iniziare ad informarsi. Ma in quanto ad analisi politica o guida per l'intervento, risulta essere severamente limitato dalla indisponibilità della Klein ad ammettere che il problema non è la pubblicità ma il capitalismo.
(tradotto ed adattato da Red & Black Revolution, rivista del WSM irlandese)